Le tutele dei lavoratori a termine durante la pandemia [E.Massi]
Analisi approfondita su tutte le tutele messe in campo dell’esecutivo per i lavoratori con contratti a termine durante la crisi sanitaria da Covid-19
Non c’è dubbio che un particolare occhio di riguardo sia stato riservato dal Legislatore, durante la crisi dovuta al COVID-19, ai lavoratori con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione: ne sono palese testimonianza sia l’art. 19-bis del D.L. n. 18 che l’art. 93 del D.L. n. 34, recentemente convertito, con modificazioni, nella legge n. 77. Se la prima norma che ho appena citato appare coerente in un momento in cui la pandemia aveva tragicamente attanagliato il nostro Paese, la seconda che si sostanzia in due commi, tra loro parzialmente correlati, offre il fianco ad alcune criticità.
Ma andiamo con ordine, cercando di fare un minimo di chiarezza.
Con una norma di interpretazione autentica, un po’ inusuale, che risulta dal titolo della rubrica e che tende (giustamente, sul concreto piano operativo) a salvaguardare le proroghe ed i rinnovi di contratti a tempo determinato disposti dalle imprese che sapevano di dover ricorrere agli ammortizzatori sociali: era un momento particolare e il Legislatore, modificando tre articoli del D.L.vo n. 81/2015, ha consentito ai lavoratori a tempo determinato di fruire degli ammortizzatori sociali che, altrimenti, sarebbero terminati con la cessazione dei contratti. Ci sono state, al momento, diverse critiche allo strumento adoperato, ma il fine (che era quello di assicurare, una tutela di sostegno del reddito al di fuori della NASPI anche a questi lavoratori) giustifica l’intervento normativo, attesa la situazione emergenziale. Il Legislatore sembra dire alle imprese, un po’ renitenti: non vi preoccupate, l’integrazione salariale COVID-19 non è a vostro carico, voi non avete costi (ad eccezione del TFR).
Con l’art. 93 del D.L. n. 34, invece, le cose cominciano ad ingarbugliarsi già dal comma 1 ove si stabilisce che, alfine di agevolare il riavvio dell’attività dopo la crisi dovuta al COVID-19, per i contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020, è possibile la proroga o il rinnovo, senza l’apposizione di alcuna causale, fino al 30 agosto p.v.: il tutto in deroga alla previsione dell’art. 21 del D.L.vo n. 81/2015.
Qui il Legislatore ha fatto una scelta precisa: ad essere privilegiati (mi si passi il termine pur in presenza di una situazione economica così pesante) sono soltanto i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020 (quindi, coloro che, magari, hanno fruito di interventi integrativi salariali, anche per effetto dell’art. 19-bis) mentre restano esclusi sia coloro che hanno visto il loro rapporto terminare prima del 23 febbraio o che (penso ad aziende alimentari o del settore farmaceutico che durante la pandemia hanno incrementato l’attività) non erano in forza a tale data. Questi lavoratori restano esclusi dalla possibilità di essere assunti a termine, sia pure per un breve periodo, in quanto il 30 agosto è ormai alle porte, perché non erano in forza alla data sopraindicata. Ovviamente, pur non essendo stati espressamente richiamati dalla norma, le stesse regole valgono anche per i contratti di somministrazione, attesa la piena equiparazione, di questi ultimi con i contratti a tempo determinato, realizzatasi, compiutamente, con le modifiche del D.L.vo n. 87/2018, intervenute nel “corpus” del D.L.vo n. 81/2015.
Il Legislatore ha, quasi, paura di andare oltre il 30 agosto (la data poteva, ben essere interpretata, come ultimo giorno utile per sottoscrivere la proroga o il rinnovo ma la slide del Ministero del Lavoro – a proposito, non si parla più con circolari amministrative – non lascia dubbi al riguardo): ma allora mi chiedo se il “riavvio dell’attività” che è nell’”incipit” della disposizione, è un cosa vera alla quale si crede, perché limitarla al 30 agosto? Misteri del Legislatore.
Ma è con il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, che, a mio avviso, si raggiunge il limite massimo di criticità: i datori di lavoro che hanno in forza lavoratori a tempo determinato, anche in somministrazione (la disposizione sembra escludere i rapporti terminati prima del 18 luglio, data di entrata in vigore della legge di conversione) e che, durante la crisi pandemica, nel rispetto dell’art. 19-bis hanno provveduto a mettere in integrazione salariale i loro dipendenti a tempo determinato, sono obbligati a prorogare i rapporti per un periodo identico a quello della sospensione dell’attività. La stessa disposizione riguarda i contratti di apprendistato di primo e terzo livello ma qui ci troviamo di fronte ad un contratto a causa mista a tempo indeterminato (art. 41 del D.L.vo n. 81/2015) e la disposizione non fa altro che ripetere quanto detto dall’art. 2, comma 4, del D.L.vo n. 148/2015 a proposito dell’apprendistato professionalizzante. Così come è scritta, la disposizione riguarda tutti i datori di lavoro, pur se il buon senso, porta ad escludere quelli che sono in procedura concorsuale senza continuazione dell’attività e quelli che magari hanno cessato l’attività, riconsegnando la licenza di esercizio e che non hanno potuto procedere ai recessi per la sospensione dei licenziamenti decretata dall’art. 46 del D.L. n. 18 fino al prossimo 17 agosto.
Prima di entrare nel merito di una serie di questioni critiche, credo che il riferimento che il comma 1-bis fa alla sospensione comprenda non soltanto la c.d. “sospensione a zero ore” ma anche le ore di lavoro perse in caso di riduzione di orario. Credo, infatti, salvo indicazioni amministrative diverse, che il concetto da prendere a riferimento sia proprio quello espresso per l’apprendistato professionalizzante dalla disposizione appena citata: lì, infatti, si fa riferimento all’ammontare delle ore fruite. Per la verità, il Ministero del Lavoro con una FAQ (ma quale è il valore giuridico?) apparsa sul proprio sito web il giorno 27 luglio 2020 afferma che nel concetto di sospensione da far valere sia per l’apprendistato di primo e terzo livello che per i contratti a tempo determinato o in somministrazione a termine nel concetto di “periodi di sospensione” vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale COVID-19, sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19 (es. fruizione di ferie). Ma mi chiedo, cosa c’entrano le ferie godute che come istituto sono già pagate dal datore di lavoro? E nel concetto di inattività, secondo il richiamo della FAQ, rientrano anche i permessi ed i congedi a vario titolo, anche quelli dettati dall’emergenza coronavirus e “coperti” da una indennità? Credo, personalmente, che l’interpretazione ministeriale sia un abbaglio e che, anche per una sorta di richiamo ad una norma già esistente nel nostro ordinamento, l’art. 2, comma 4, del D.L.vo n. 148/2015, ci si sarebbe dovuti fermare al recupero delle ore di integrazione salariale non lavorate.
La norma introdotta, relativa ai contratti a tempo determinato rappresenta una sorta di “imponibile di manodopera” che, è bene ricordarlo, fu, in altro settore (agricoltura) ed in un contesto ben diverso, dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 78 del 16 dicembre 1958 (a cadere sotto la scure fu un Decreto del Capo provvisorio dello Stato del 1947). Tale concetto di “imponibile obbligatorio” scaturisce dal fatto che il Legislatore ha dimenticato che il rapporto a termine nasce per esigenze dell’azienda, esigenze che, al momento, potrebbero non esserci più: è il caso, ad esempio, della causale “ragioni sostitutive” ove, nel frattempo, potrebbe essere tornata la titolare del posto dalla maternità o un altro dipendente dalla malattia, dalle ferie o dall’infortunio. A ciò si aggiunga il fatto che il lavoratore potrebbe essere stato assunto per una attività di una impresa stagionale prima del lockdown ed, ora, al termine dell’integrazione salariale COVID-19, la stagionalità potrebbe essere terminata. Che si fa? Si lascia aperta l’attività per consentire il recupero del periodo integrativo che potrebbe essere abbastanza lungo sol che si pensi, ad esempio, ad una sospensione dell’attività per nove settimane che, secondo il messaggio INPS n. 2825 del 15 luglio 2020 abbraccia un range compreso tra 57 e 65 giornate (ovviamente, con diciotto, il valore si raddoppia)? Misteri ai quali il Legislatore non da risposte ma neanche gli organi amministrativi del Ministero del Lavoro hanno pensato di dire alcunchè.
Ma cosa succede se il datore di lavoro (la norma si rivolge anche ai piccoli) non ha le mansioni alle quali adibire il lavoratore?. Lo deve impiegare in mansioni inferiori o superiori ma, allora, non si può parlare di proroga ma di rinnovo, che segue altre regole (è obbligatoria la causale e lo “stop and go”) ed, allora, andremmo a fare qualcosa che la norma non richiede.
La proroga “ex lege” consente di sforare il numero massimo di quattro previsto dall’art. 21 del D.L.vo n. 81/2015 ma il periodo ulteriore non è stato “neutralizzato” ai fini della durata massima: probabilmente, lo è implicitamente, ma avrebbe fatto bene il Legislatore a dirlo chiaramente.
Il periodo ulteriore può far scattare il diritto di precedenza per una assunzione a tempo indeterminato secondo le previsioni dell’art. 24 del D.L.vo n. 81/2015 ma anche per uno a termine in caso di donna nel c.d. “periodo protetto da astensione obbligatoria”, in caso di superamento del termine fissato, anche in sommatoria, in sei mesi.
Ci sono, poi, altre questioni che, in alcune situazioni, potrebbero venire in evidenza: mi riferisco al collocamento obbligatorio ove la computabilità nella base di calcolo scatta con il superamento della soglia dei sei mesi, mi riferisco alla inottemperanza del datore di lavoro che dovesse rifiutare la proroga e che potrebbe essere convenuto in giudizio dall’interessato con una richiesta di risarcimento del danno.
Come si vede, si tratta di una norma che non tiene conto di un fatto fondamentale: i lavoratori a tempo determinato vengono, temporaneamente, chiamati a prestare la propria attività in un’azienda perché c’è bisogno e le stesse causali previste dall’art. 19, introdotte con il c.d. “Decreto Dignità” stanno li a dimostrarlo. Come si fa ad imporre ad un datore di lavoro, già gravato dalla crisi pandemica, l’onere di un contratto a termine per un periodo abbastanza lungo per dei lavoratori di cui non ha bisogno (e, magari, deve pagare, se dovuto, oltre l’10% anche il contributo progressivo dello 0,50%)? Quando si è modificata la disposizione per consentire ai lavoratori in scadenza di fruire dell’ammortizzatore sociale COVID-19, si disse che la modifica era “a costo zero” per le aziende perché gli oneri gravavano sulle finanze pubbliche. Bene, ma questa proroga, invece, grava sulle casse dei singoli datori di lavoro e questo non è bene se, gli stessi non hanno, materialmente, la possibilità d’impiego.
Per la somministrazione a termine il discorso è del tutto analogo a quello dei contratti a tempo determinato con un codicillo in più: per poter utilizzare il lavoratore somministrato per un altro periodo occorre stipulare o quantomeno, modificare, il precedente contratto di natura commerciale tra l’Agenzia di Lavoro e l’impresa utilizzatrice.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.





 Nuovi bonus per assunzioni: Incentivi a giovani, donne e ZES
Nuovi bonus per assunzioni: Incentivi a giovani, donne e ZES Rassegna stampa del 28 Maggio 2024
Rassegna stampa del 28 Maggio 2024
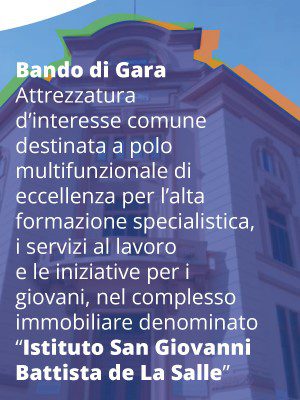
8 Commenti
Avv. Noemi Ratto
Settembre 02, 20:30Buonasera volevo avere un confronto su un punto non chiaro della norma.
Nell’incipit si fa riferimento alla necessità di “agevolare il riavvio delle attività” Appunto nella fase c.d. 2 in cui si procedeva alle “riaperture e riavvio delle attività produttive”.
Ebbene, se ne deduce che un’azienda che non è stata interessata dalla chiusura obbligatoria nella fase di lockdown, secondo le determinazioni governative, non avrebbe potuto essere, a rigore, legittimata ad un rinnovo a-causale in deroga alle disposizioni ordinarie non essendo la sua attività, alla data di entrata in vigore della norma, in fase di “riavvio”.
Eufranio Massi
Settembre 03, 11:59La frase contenuta nel testo dell’originario art. 93 del D.L. n. 34/2020 poteva ingenerare, soprattutto in sede di contenzioso, l’idea che la deroga alla normativa generale riguardasse soltanto le imprese che avevano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali CoViD. Ora, il D.L. n. 104/2020 l’ha cancellata e l’ha sostituita con un’altra che può benissimo essere riferita a tutti i datori di lavoro interessati alla proroga o al rinnovo dei contratti a termine senza causale da stipulare entro il 31 dicembre.
Dott. Eufranio Massi
Cristiano
Agosto 07, 03:52Buonasera, qualora il lavoratore rifiuti la proroga ex-lege può accedere lo stesso alla NASPI?
Eufranio Massi
Settembre 03, 12:01La NASPI è legata ad una disoccupazione involontaria: il rifiuto della proroga non mi sembra che abbia tali caratteristiche. In ogni caso, attendiamo i chiarimenti dell’Inps.
Dott. Eufranio Massi
fabio
Agosto 01, 09:32Dr. Massi buongiorno.
Un lavoratore a termine può’ comunicare ufficialmente alla scadenza contrattuale di non voler essere più’ prorogato, oppure sussiste comunque l’obbligo datoriale di proroga a prescindere dalla volontà’ contraria del lavoratore?
Grazie mille
Grazia Compagnoni
Luglio 31, 14:53Grazie dell’approfondimento. Chiedo, lato lavoratore, se la proroga ex lege può essere dallo stesso rifutata, concludendo così’ il contratto a termine alla sua data originaria.
Grazie Grazia Compagnoni.
Eufranio Massi
Agosto 05, 17:01Si, può senz’altro rifiutarsi.
Dott. Eufranio Massi
Filippo Leodori
Luglio 31, 14:42BUONASERA
UNA DOMANDA PER CAPIRE MEGLIO.
SI STA PARLANDO DEI RAPPORTI A TERMINE CON SCADENZA NEI MESI DELLA PANDEMIA E CHE HANNO BENEFICIATO DI INTEGRAZIONE SALARIALE?
ALTRA DOMANDA:
MA SE IO HO COMUNQUE PROROGATO IL CONTRATTO A TEMINE DURANTE QUESTO PERIODO E HO INSERITO UNA CAUSALE COME STABILITO DAL DECRETO DIGNITA’, NON HO L’OBBLIGO DI PROROGARLO SOLO FINO AL 30 AGOSTO GIUSTO?