Il tentativo obbligatorio di conciliazione nei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo [E.Massi]
Problemi, soluzioni e procedure adottate in via amministrativa per le questioni relative ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
Le questioni relative ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e, soprattutto, le procedure da seguire, sono, da sempre, oggetto di riflessione tra gli addetti ai lavori, in quanto diverse sono le regole che trovano applicazione.
Il Dicastero del Lavoro con la circolare n. 3 del 16 gennaio 2013 fornì le indicazioni operative alle proprie strutture territoriali in ordine alla procedura obbligatoria di conciliazione concernente i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dopo le novità introdotte con la legge n. 92/2012 che con il comma 40 dell’art. 1, ha riformato l’art. 7 della legge n. 604/1966: l’analisi che segue cercherà di mettere in evidenza i problemi e le soluzioni adottate in via amministrativa, non dimenticando come altre soluzioni, siano previste per altre aziende con limiti dimensionali diversi, come quelle con un organico dimensionato sotto le quindici unità o datori di lavoro con lavoratori assunti attraverso le c.d. “tutele crescenti”.
Proprio riferendosi a tale ultima ipotesi è bene ricordare che la procedura ex art. 7 non riguarda gli assunti dai datori di lavoro a partire dal 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 23/2015, per i quali la norma ha abrogato il tentativo obbligatorio di conciliazione ed ha previsto, soltanto, la possibilità dell’offerta conciliativa, peraltro facoltativa, secondo l’iter procedimentale contenuto nell’art. 6 del predetto decreto. Tale procedura, tuttavia, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 194 dell’8 novembre 2018, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 3, comma 1, nella parte in cui correla l’indennità risarcitoria al solo requisito, seppur importante, dell’anzianità aziendale, ha perso molto del precedente “appeal”, soprattutto nelle imprese che occupano più di quindici dipendenti. Infatti, mentre, in precedenza il lavoratore poteva ottenere con la conciliazione, subito, una somma, ad accettazione del licenziamento, pari al 50% di ciò che avrebbe ottenuto andando in giudizio (l’esenzione dall’IRPEF e la mancanza di spese legali facevano lievitare l’importo), ora, il fatto che il giudice possa integrare la predetta indennità correlata all’anzianità con i criteri evidenziati dall’art. 8 della legge n. 604/1966 (numero dei dipendenti, contesto socio economico, comportamento tenuto dalle parti, ecc.) e che l’ammontare della stessa venga definito, dopo le modifiche introdotte con il D.L. n. 87/2018, tra un minimo di sei mensilità ed un massimo di trentasei calcolate sull’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, rendono la via del giudizio più appetibile per il lavoratore.
A quanto appena detto va aggiunto, a dimostrazione che il campo di applicazione della obbligatorietà andrà sempre di più a restringersi che nella procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966 non rientrano:
- i dirigenti;
- i lavoratori licenziati al superamento del periodo di comporto ex art. 2110 c.c., per effetto di una specifica aggiunta nel “corpus” dell’art. 7 dal D.L. n. 76/2013, dopo che, nel merito vi erano stati orientamenti difformi tra i giudici di merito;
- i lavoratori licenziati al termine di un appalto, laddove clausole sociali o contrattuali abbiano previsto una loro ricollocazione presso il nuovo appaltatore o in edilizia al termine del cantiere o per fine fase lavorativa (art. 2, comma 34, della legge n. 92/2012);
- i lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato prima del 7 marzo 2015, il cui rapporto sia stato convertito dopo tale data (art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 23/2015). Di recente, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 383/2019, ha distinto tale ipotesi da quella della trasformazione ove le tutele da applicare restano quelle dell’art. 18 della legge n. 300/1970;
- i lavoratori assunti con contratto di apprendistato entro il 6 marzo 2015 il cui rapporto sia stato consolidato al termine del periodo formativo (art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 23/2015);
- i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 da aziende il cui requisito dimensionale, all’epoca, non integrava le ipotesi previste dai commi 8 e 9 dell’art. 18, ma che, per effetto, delle nuove assunzioni, hanno superato tali soglie (art. 1, comma 3, del D.L.vo n. 23/2015).
Reputo, a questo punto, opportuno soffermare l’attenzione sulle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e sugli adempimenti conseguenti che fanno carico sia agli Ispettorati territoriali del Lavoro che alle commissioni provinciali di conciliazione che operano ex art. 410 cpc.
Le prima impressione che si trae dalla lettura della circolare n. 3/2013 (successivamente, il Ministero del Lavoro non ha fornito altre indicazioni) è quella di un chiarimento amministrativo abbastanza puntuale che richiama, in diversi punti, le articolazioni periferiche dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (che hanno ereditato i compiti delle vecchie Direzioni territoriali del Lavoro) adempimenti veloci e, se possibile, in linea con la volontà del Legislatore che ha ipotizzato questo iter con lo scopo di “sgravare”, nei limiti del possibile, la Magistratura da ricorsi che possono trovare anche una soluzione di natura extra – giudiziale. Si parla di coinvolgimento degli Uffici a tutti i livelli ivi compresi quelli di supporto (segreteria e protocollo per far partire celermente le lettere di convocazioni), urp ed ispettore di turno (per le informazioni sulle novità normative) e non soltanto il personale addetto e la commissione provinciale di conciliazione che deve trattare la controversia. Il Ministero parla della assoluta necessità di evitare i “tempi morti”, di rispettare i termini precisi, brevi e perentori previsti dalla procedura, di prevedere la possibilità di convocazioni straordinarie dell’organo conciliativo e di razionale organizzazione tale da ottemperare alle indicazioni ministeriali: l’inosservanza potrà incidere sulla valutazione del comportamento organizzativo dei Dirigenti e delle rispettive strutture (immagino, che tale ultima indicazione sia rimasta anche nelle valutazioni del nuovo organismo Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Giustificato motivo oggettivo e datori di lavoro coinvolti alla procedura
Detto questo, la nota ministeriale si sofferma sul concetto di giustificato motivo oggettivo rispetto al quale è obbligatorio effettuare il tentativo di conciliazione. Si parla di ristrutturazione di reparti, di soppressione del posto di lavoro, di terziarizzazione e di esternalizzazione delle attività. Come si vede, si tratta di ipotesi che scaturiscono dai principi fissati dall’art. 3, seconda parte, della legge n. 604/1966 e che fanno riferimento alla necessità di dover “cancellare” quel posto di lavoro nel quadro dell’organizzazione e del funzionamento dell’impresa ed alla impossibilità di una qualsiasi altra utilizzazione all’interno dell’azienda. La dottrina e la giurisprudenza hanno previsto altre ipotesi di licenziamento che fanno riferimento alla inidoneità fisica, alla impossibilità di “repechage” anche all’interno del “gruppo d’imprese), a provvedimenti di natura amministrativa che incidono sul rapporto come, ad esempio, il ritiro della patente di guida ad un autista o del porto d’armi ad una guardia particolare giurata.
Il Ministero invita gli Ispettorati territoriali del Lavoro, a verificare se, in un arco temporale di 120 giorni, il datore di lavoro l’impresa effettui o abbia effettuato più di quattro licenziamenti: se ciò dovesse accadere, a fronte di specifiche richieste di attivazione del tentativo obbligatorio, l’Ufficio è tenuto ad invitare l’impresa ad aprire la procedura collettiva di riduzione di personale prevista dalla legge n. 223/1991, non potendo effettuarsi i singoli tentativi conciliativi. Ovviamente, il discorso non si pone, ad esempio, per l’edilizia ove, per fine cantiere o fase lavorativa, l’iter procedimentale della legge n. 223/1991 non si applica (art. 24, comma 4).
Fatta questa breve premessa ritengo necessario verificare, nel concreto, le modalità applicative partendo dalla individuazione dei soggetti nei confronti dei quali trova applicazione.
La circolare n. 3, ripetendo quanto contenuto nei commi 8 e 9 del nuovo articolo 18 della legge n. 300/1970, come modificato dal comma 42 dell’art. 1 della legge n. 92/2012, afferma che sono tenuti al rispetto della norma tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo abbiano alle proprie dipendenze più di quindici unità o più di cinque se imprenditori agricoli: la disposizione trova applicazione anche nei confronti del datore, imprenditore o non imprenditore, che nello stesso ambito comunale occupi più di quindici lavoratori, pur se ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti (anche per l’imprenditore agricolo dimensionato oltre le cinque unità vale lo stesso principio) e, in ogni caso, a chi occupa più di sessanta dipendenti. Ai fini del computo i lavoratori a tempo parziale indeterminato sono calcolati “pro – quota” in relazione all’orario pieno contrattuale (art. 6 del D.L.vo n. 61/2000), mentre non si computano il coniuge ed i parenti entro il secondo grado sia in linea diretta che collaterale. A tale casistica, a mio avviso, va, poi, aggiunta l’ipotesi prevista dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 23 aprile 1998: allora di parlava della c.d. “tutela reale”, oggi si può affermare, alla luce delle novità introdotte, che la nuova procedura (che non necessariamente, in caso di licenziamento illegittimo porta alla reintegra) può essere estesa anche ai lavoratori dipendenti dalle imprese dimensionate sotto le sedici unità, qualora le stesse, in sede di contrattazione collettiva, si siano impegnate a garantire tale maggiore tutela.
La previsione relativa “all’ampiezza aziendale”, ricalca quanto già affermato dal Legislatore del 1970: da ciò scaturisce la piena validità di alcuni indirizzi consolidatisi nel corso degli anni passati presso la Suprema Corte come quello secondo il quale il calcolo della base numerica deve essere effettuato non già nel momento in cui avviene il licenziamento, ma avendo quale parametro di riferimento la c.d. “normale occupazione” nel periodo antecedente, senza tener conto di occasionali contrazioni dell’occupazione. Il datore di lavoro, sul quale grava, in giudizio, l’onere di dimostrare l’esistenza dei requisiti che lo portano al di sotto della “soglia” (Cass., n. 7227/2002), può provare che il calo è stato determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive (v. Cass., n. 2546/2004; Cass. n. 13274/2003; Cass., n. 12909/2003; Cass., n. 5092/2001). Tale problema risulta ancora più accentuato in quelle aziende ove, per motivi di mercato o di attività svolta in periodi predeterminati, l’occupazione è “in un certo senso” fluttuante: qui la giurisprudenza, fermo restando che l’onere della prova circa la consistenza numerica spetta al lavoratore, è oscillata tra un concetto di media (Cass. n. 2546/2004) ed uno di “normalità” della forza lavoro, riferita all’organico necessario in quello specifico momento dell’anno (Cass., n. 2241/1987; Cass., n. 2371/1986).
Ma quali sono i prestatori di lavoro subordinato che, in ogni caso, non rientrano nel calcolo numerico per l’individuazione della soglia di applicazione? Qui, il riferimento sono alcuni indirizzi legislativi che nel corso degli anni hanno portato alla esclusione di alcuni soggetti e, precisamente:
- gli assunti con rapporto di apprendistato (qualunque sia la tipologia ed ivi compresi i c.d. “apprendisti in mobilità” (ormai, inesistenti, atteso che l’iscrizione nelle liste di mobilità non è più possibile dal 1 gennaio 2017), o quelli titolari di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età, in quanto l’art. 47, comma 3, del D.L.vo n. 81/2015 li esclude espressamente;
- gli assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991, pur se tale tipologia è rimasta nel nostro ordinamento quale mero “retaggio storico”, atteso che è rimasta pressoché inutilizzata dal momento della sua emanazione, resistendo, curiosamente, anche agli interventi abrogativi che hanno riguardato il contratto di inserimento previsto dagli articoli 54 e ss. del D.L.vo n. 276/2003;
- gli assunti, già impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, secondo la previsione contenuta nell’art. 7, comma 7, del D.L.vo n. 81/2000 (norma, ormai, finita nel “dimenticatoio”);
- i lavoratori somministrati che non rientrano nell’organico dell’utilizzatore;
Vanno, invece, compresi nell’organico aziendale:
- i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro che, successivamente all’associazione, hanno sottoscritto un contratto di lavoro subordinato secondo la previsione contenuta nell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori sportivi professionisti, con rapporto di lavoro subordinato che, pur essendo trattati, in materia lavoristica, in modo del tutto “speciale” dalla legge n. 91/1981 (non trovano, ad esempio, applicazione gli articoli 5, 7 e 18 della legge n. 300/1970), rientrano nel computo dimensionale del proprio datore di lavoro;
- i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, con l’ovvia esclusione dal computo dei loro sostituti.
Il computo parziale nell’organico non riguarda soltanto i lavoratori ad orario ridotto a tempo indeterminato come detto, esplicitamente, dalla norma, ma anche quelli intermittenti, grazie all’art. 18 del D.L.vo n. 81/2015, che li calcola nell’organico aziendale “ai fini dell’applicazione di norme di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nel’arco di ciascun semestre”.
L’obbligatorietà del tentativo di conciliazione nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per il datori di lavoro sovra dimensionati alle quindici unità ha alcune dirette conseguenze che sono, di seguito, evidenziate:
- la procedura è una deroga generale al regime di facoltatività, introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 183/2010;
- l’individuazione quantitativa sopra considerata fa sì che tale rito procedimentale non possa applicarsi alle piccole imprese per le quali resta la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro con le modalità già introdotte con la legge n. 108/1990, per la quale, in caso di licenziamento illegittimo (fatto salvo, in ogni caso, quello discriminatorio per il quale valgono le regole generali con la reintegra) è prevista una indennità di natura risarcitoria compresa tra le 2,5 e le 6 mensilità, aumentabili fino a 10 o 14 in presenza di particolari condizioni. Va, peraltro, ricordato che, per effetto del D.L.vo n. 23/2015 per tutti i nuovi assunti – data di discrimine il 7 marzo 2015 – (sia per le piccole che per le imprese dimensionate oltre le 15 unità) non trova più applicazione il tentativo obbligatorio ma c’è la possibilità dell’offerta conciliativa, di natura facoltativa, prevista dall’art. 6 del predetto decreto;
- non applicabilità della procedura significa che in caso di accordo, con risoluzione consensuale del rapporto nelle imprese con un organico fino a quindici dipendenti, il lavoratore non può iscriversi nelle liste di disoccupazione e percepire la NASPI, atteso che il Legislatore ha riservato tale possibilità soltanto alle imprese che sono obbligate a seguire la procedura prevista dal nuovo art. 7 della legge n. 604/1966. Per poter “godere” della NASPI, il lavoratore dipendente da una piccola impresa deve essere licenziato;
- la specificità della procedura, fa sì che per gli effetti strettamente correlati non possano essere prese in considerazione altre forme di conciliazione come quella, ad esempio, in sede sindacale ex art. 411 cpc. Infatti, non è possibile ottenere la NASPI a seguito di risoluzione consensuale raggiunta in quella sede e, al contempo, nel caso in cui un licenziamento sia stato adottato dopo la conclusione di un incontro presso tale sede, si potrebbe verificare, con ricorso in giudizio, l’ipotesi prevista dal comma 6 del nuovo art. 18: il giudice, nel dichiarare inefficace il recesso per violazione della procedura ex art. 7 della legge n. 604/1966, applica la c.d. “indennità risarcitoria onnicomprensiva in misura ridotta”, compresa tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e determinata in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro. Per la verità, l’interpello n. 1/2014 del Ministero del Lavoro ha ritenuto possibile un accordo sottoscritto “in sede protetta” ex art. 411 cpc nel quale, senza aver fatto ricorso al tentativo obbligatorio, il lavoratore accetti il licenziamento dichiarando, al contempo, la propria volontà di non ricorrere in giudizio anche per questioni di natura formale o procedurale.
Motivazione del licenziamento e procedura
Pensando ad una forma del tutto originale di tentativo obbligatorio di conciliazione, il Legislatore ha pensato la procedura prevista dal comma 40 dell’art. 1 della legge n. 92/2012, prendendo quale riferimento quella di riduzione di personale, i cui tempi procedurali sono dettati dagli articoli 4 e 5 della legge n. 223/1991. Lo spunto è quello ma, come sottolineo in diversi passaggi, i contenuti e le modalità sono molto diversi, sol che si pensi all’assenza di ruolo del sindacato interno dell’azienda nella procedura ipotizzata dall’art. 7 della legge n. 604/1966.
C’è, innanzitutto, da parlare della motivazione del licenziamento.
La circolare n. 3, sottolinea, quasi ce ne fosse bisogno, che nella fase di apertura della procedura essa è rimessa alla sola valutazione del datore di lavoro, secondo la previsione contenuta nell’art. 3, seconda parte, della legge n. 604/1966. Del resto, questo è l’orientamento della Suprema Corte (v., tra le altre, Cass., 9 luglio 2012, n. 11465), la quale ha affermato che il recesso per giustificato motivo oggettivo le cui motivazioni riguardano strettamente l’attività produttiva (fatta salva l’ipotesi della pretestuosità), non può essere sindacabile dal giudice di merito sotto l’aspetto economico ed organizzativo, atteso che questo è un campo strettamente riservato alla scelta imprenditoriale.
Chi, trovandosi nelle dimensioni occupazionali sopra indicate, intende procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve inviare una comunicazione scritta all’ Ispettorato territoriale del Lavoro, competente per territorio e, per conoscenza, al diretto interessato. La comunicazione è oltre modo fondamentale, in quanto consente di conoscere le motivazioni alla base del provvedimento di recesso che si intende porre in essere. Nella nota, il datore di lavoro, deve, a mio avviso, dare “contezza” della impossibilità di procedere ad una nuova collocazione del dipendente (ai fini del c.d. “repechage”), anche dopo aver espletato una serie di valutazioni correlate all’ art. 2103 c.c. (variazione di un livello in meno all’interno della stessa categoria legale di inquadramento, con mantenimento della retribuzione di provenienza e con la sola perdita delle indennità legate alla precedente posizione, mancato accordo circa un demansionamento effettuato “in sede protetta”). Per evitare lungaggini nella procedura è auspicabile che il datore di lavoro comunichi anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Fatte queste brevi premesse, mi sembra necessario chiarire alcuni aspetti fondamentali.
Il primo riguarda l’individuazione dell’articolazione periferica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro interessata: essa è quella sulla quale insiste il luogo in cui si svolge l’attività del lavoratore. Fori alternativi, che pure, per le controversie di lavoro sono individuati per le controversie di lavoro dall’art. 413 cpc, in questo caso non sono presi in considerazione.
Il secondo chiarimento concerne le motivazioni. Queste vanno indicate unitamente alle eventuali misure finalizzate ad una ricollocazione: a mio avviso, rispetto alla procedura prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991, le motivazioni vanno, se possibile, meglio specificate, atteso che, in questo caso, il datore di lavoro ha già fatto la propria scelta, mentre nell’iter sui licenziamenti collettivi, l’imprenditore ha evidenziato la situazione di crisi e le cause, ma non ha ancora individuato i lavoratori oggetto del licenziamento, cosa che avverrà secondo i criteri individuati con l’accordo sindacale o, in alternativa, utilizzando quelli individuati, in concorso tra loro, dall’art. 5 della legge n. 223/1991 (anzianità, carico familiare, esigenze tecnico produttive).
Ricevuta la richiesta, “la palla” passa all’ Ispettorato territoriale del Lavoro che senza particolari indugi deve sollecitamente metterla a convocazione, in quanto i tempi sono molto ristretti, perché trascorsi sette giorni dalla ricezione, senza che sia trasmessa la convocazione, il datore di lavoro (comma 6) può procedere al licenziamento del lavoratore.
Il termine è “ope legis” perentorio e non ammette letture diverse. Forme alternative di convocazione, rispetto alla lettera raccomandata, al di fuori della “pec” non sono previste, attesa la necessità di coniugare la certezza dell’invio con l’effettiva conoscenza del giorno e dell’ora dell’incontro.
I tempi della procedura sono oggettivamente ristretti e nel computo dei venti giorni complessivi, “sforabili” di comune accordo dalle parti anche su richiesta della commissione (“rectius” sotto commissione di conciliazione, in quanto è questa la composizione più ricorrente dell’organo di mediazione) vanno compresi anche quelli necessari per far sì che la nota di convocazione giunga alle parti. Non convocarle per l’espletamento del tentativo entro i venti giorni, se da un lato consente al datore di lavoro di considerare esaurita la procedura e, di conseguenza, di poter procedere al licenziamento (comma 6), dall’altro significa vanificare la procedura.
Le parti possono essere presenti personalmente o per delega e, al contempo, possono farsi assistere sia da avvocati e consulenti del lavoro (iscritti all’albo, puntualizza la circolare n. 3, con esclusione dei professionisti equiparati ex lege n. 12/1979) che da rappresentanti dell’associazione datoriale o sindacale cui aderiscano o abbiano conferito mandato.
Alcune considerazioni vanno effettuate anche su questo passaggio della circolare che, peraltro, ripete, quasi pedissequamente, il dettato normativo. Il datore di lavoro ed il lavoratore possono farsi assistere, qualora lo desiderino, dalla organizzazione datoriale o sindacale prescelta, senza che, ovviamente, riverberino problemi legati alla rappresentanza. La stessa cosa può dirsi per i professionisti (avvocati e consulenti del lavoro).
Piuttosto, la questione principale riguarda la delega: superando il concetto espresso con la nota del 25 novembre 2010, a firma del Segretario Generale del Ministero del Lavoro, secondo il quale nelle controversie di lavoro avanti alla commissione di conciliazione la delega poteva essere soltanto notarile o autenticata da un funzionario dell’ Ispettorato del Lavoro, la circolare n. 3 sposa una tesi più ampia ed in linea con quanto, in passato, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva aveva affermato per le conciliazioni monocratiche: in sostanza, sono pienamente valide anche le deleghe sottoscritte dalle parti, unitamente a copia del documento di identità, o l’autentica rilasciata dallo stesso avvocato che rappresenta ed assiste il proprio cliente. Tale ultima possibilità trae forza anche dal fatto che, trattandosi di un tentativo obbligatorio, propedeutico all’eventuale giudizio, non si comprenderebbe perché un legale possa autenticare la firma del proprio cliente in sede di presentazione del ricorso giudiziale e non per un tentativo di conciliazione avanti ad un organo amministrativo.
Altra questione, sostanziale, riguarda la presenza effettiva delle parti: si è detto della delega ma, sul piano estremamente pratico, è opportuno che, quanto meno, il lavoratore sia presente perché nel corso della discussione potrebbero emergere soluzioni alternative al licenziamento che possono essere diverse ed articolate, ma che solo l’interessato può valutare fino in fondo.
Entrando nel merito delle questioni relative allo svolgimento del tentativo di conciliazione, il Ministero osserva che l’assenza, non giustificata, del lavoratore, con la conseguente redazione del verbale di assenza, abilita il datore di lavoro ad attuare il recesso, intendendosi concluso l’iter procedimentale, mentre la stessa cosa non può dirsi nel caso contrario. La procedura ha, come si è detto più volte, tempi ristretti e “cadenzati”, non consente atteggiamenti dilatori e deve concludersi entro i venti giorni successivi a quello in cui è stata inviata la convocazione. Il termine anzidetto (che “sconta”, come si è detto, anche i giorni necessari alla nota di convocazione per giungere a destinazione), può essere superato, qualora le parti, di comune accordo, lo chiedano per continuare a trattare o anche nell’ipotesi di temporanea sospensione (art. 7, comma 9) in presenza di un legittimo impedimento del lavoratore (anche autocertificabile) che va valutato dalla commissione (o sotto commissione) di conciliazione nella sua autonomia e che può consistere in uno stato di malattia, ma anche in un motivo diverso concernente la propria sfera familiare. La sospensione è prevista per un massimo di quindici giorni e, in ogni caso, non incidono sulla ulteriore durata della sospensione periodi di malattia più lunghi che vanno oltre l’arco temporale considerato. In sostanza, il Legislatore non ha voluto avallare comportamenti dilatori nella procedura, anche se supportati da certificazione medica.
L’organo conciliativo ha una funzione attiva: ciò significa che non deve stabilire chi ha ragione o chi ha torto (tale compito spetta soltanto al giudice), ma deve facilitare la soluzione positiva della controversia non soltanto facendo proposte economiche, ma anche esplorando altre possibilità che non si traducano, necessariamente, nella risoluzione del rapporto (ad esempio, trasformazione a tempo parziale, demansionamento, trasferimento in altra unità produttiva, distacco temporaneo in altra azienda, ricollocazione in altra azienda, ecc.): sta alla capacità mediatoria dell’organo collegiale ed alla sua professionalità svolgere il compito nel migliore dei modi.
Qualora l’organo collegiale debba prendere atto dell’impossibilità di giungere ad una soluzione positiva, è tenuto a redigere un verbale di mancato accordo nel quale, oltre ad essere riportate, sia pure succintamente, le posizioni delle parti, dovrà trovare posto la proposta della commissione e, soprattutto, dovranno essere riportate le posizioni delle parti in ordine alla stessa. Tutto questo perchè, in sede di ricorso, il giudice tiene conto, qualora ritenga di dover risolvere la questione con il riconoscimento di un’indennità risarcitoria, del comportamento complessivo tenuto, cosa che si riflette anche sul pagamento delle spese di giudizio. Ovviamente, il riferimento alle posizioni espresse dalle parti postula, se richiesto, la necessità che vengano riportate “questioni sostanziali ed eccezioni sollevate dal lavoratore” (ad esempio, si ritiene discriminatorio il licenziamento), o l’assoluta indisponibilità a trovare una soluzione economica.
Ma, il tentativo di conciliazione, può concludersi positivamente e le soluzioni possono essere diverse, anche alternative alla risoluzione del rapporto: in questo caso, la commissione procede alla verbalizzazione dei contenuti (si pensi, ad esempio, ad un trasferimento, alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale) che divengono inoppugnabili, trattandosi di una conciliazione avvenuta ex art.410 cpc. Se, invece, si arriva ad una risoluzione consensuale del rapporto, la commissione ne darà atto attraverso il verbale riportandone tutti gli estremi, ivi compresi quelli di natura economica.
La risoluzione consensuale del rapporto al termine del tentativo obbligatorio di conciliazione è l’ipotesi apertamente caldeggiata dal Legislatore (art. 7, comma 7, della legge n. 604/1966) che, in un certo senso, derogando alla disciplina ordinaria, riconosce il diritto alla NASPI e postula anche un possibile affidamento del lavoratore, finalizzato alla ricollocazione, ad una agenzia del lavoro (norma quest’ultima rimasta, sostanzialmente, sulla carta).
Il datore di lavoro che risolve consensualmente il rapporto, pur se ciò è intervenuto al termine della procedura conciliativa obbligatoria, è tenuto a pagare il c.d. “ticket licenziamento”, correlato all’anzianità aziendale e con un tetto massimo fissato a trentasei mesi. Tale contributo non è dovuto in quelle ipotesi nelle quali il lavoratore non “godrà” del trattamento NASPI perché, ad esempio, destinatario della pensione di vecchiaia.
La risoluzione consensuale avvenuta avanti alla commissione di conciliazione non necessita di un ulteriore passaggio attraverso il sistema telematico delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, “figlio” della procedura ipotizzata ex art. 26 del D.L.vo n. 151/2015.
La risoluzione consensuale del rapporto potrebbe, in alcuni casi, essere accompagnata anche dalla composizione di altre questioni di natura economica afferenti il rapporto di lavoro, come le differenze retributive, le ferie non godute o il trattamento di fine rapporto. Ciò è possibile che avvenga con il medesimo atto, sia pure tenendo ben separate le questioni, a condizione ci sia la piena consapevolezza e conoscenza da parte del lavoratore circa la definitività e la conseguente inoppugnabilità ex art. 410 cpc. Sta alla sensibilità dell’organo collegiale, ove dalla discussione emerga che il lavoratore non ha avuto modo di verificare il “quantum economico” offerto, stralciare la parte relativa alla “chiusura delle pendenze economiche” e definire soltanto la controversia relativa al licenziamento, rinviando, se necessario, l’incontro per gli argomenti non risolti.
Licenziamento adottato al termine della procedura ed adempimenti di natura burocratica
Se si fa un breve riepilogo di quanto, sia pure sommariamente, esaminato nel corso di questa riflessione, si possono ipotizzare i momenti e le condizioni nelle quali il datore di lavoro può procedere al licenziamento:
- entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell’ Ispettorato territoriale del Lavoro se quest’ultima non ha proceduto a convocare le parti entro il termine appena nominato, che è di natura perentoria (art. 7, comma 6, della legge n. 604/1966);
- entro venti giorni dal momento in cui l’Ispettorato territoriale del Lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro: esso è il termine entro cui il tentativo obbligatorio si deve concludere, fatte salve le eccezioni di cui si è già parlato (art. 7, comma 6, della legge n. 604/1966);
- a partire dal giorno fissato nella lettera di convocazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, se il lavoratore non si è presentato all’incontro, senza addurre alcuna giustificazione (circolare n. 3/2013 Ministero del Lavoro) o in caso di abbandono della procedura durante la discussione (cosa che va verbalizzata dall’organo collegiale);
- al termine della procedura di conciliazione conclusasi con esito negativo (art. 1, comma 41, della legge n. 92/2012).
Il licenziamento adottato ha effetto “dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato”: esso coincide con quello della ricezione, da parte dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, della comunicazione del datore relativa alla c.d. “intenzione di licenziamento”, fatto salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla indennità sostitutiva. Il periodo di eventuale lavoro svolto durante l’iter procedurale si considera come “preavviso lavorato”. Lo scopo che si è posto il Legislatore è quello di individuare una data certa e “legale” di risoluzione del rapporto, con lo scopo di evitare possibili ed ipotizzabili rallentamenti di natura procedurale. Ovviamente, il licenziamento avvenuto nel periodo di tutela della maternità è “nullo alla radice” e, al contempo, la circolare n. 3 sottolinea l’effetto sospensivo sul recesso nel periodo di tutela della maternità e della paternità e in quello dell’infortunio sul lavoro. La malattia, invece, non genera alcun effetto sospensivo.
La nota ministeriale si preoccupa degli obblighi di comunicazione di cessazione del rapporto richiamando la lettera del 12 settembre 2012 secondo la quale “esigenze di certezza in ordine agli esiti della procedura impongono di individuare come dies a quo ai fini della comunicazione in questione quello della risoluzione del rapporto senza tener conto della circostanza secondo la quale la stessa risoluzione produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato, come prevede la nuova normativa introdotta dalla legge n. 92/2012”. In questi casi, gli effetti retroattivi del licenziamento non incidono sul termine di effettuazione della comunicazione obbligatoria on-line al centro per l’impiego che è di cinque giorni dalla data di effettiva cessazione del rapporto. La sanzione, in caso di inottemperanza, è compresa tra 100 e 500 euro, onorabile con il pagamento in misura ridotta pari a 100 euro oltre alle spese di notifica.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.





 Le assunzioni agevolate del decreto coesione
Le assunzioni agevolate del decreto coesione Appalti e somministrazione: cosa cambia con il D.L. 19/2024
Appalti e somministrazione: cosa cambia con il D.L. 19/2024 Rassegna stampa del 22 Maggio 2024
Rassegna stampa del 22 Maggio 2024
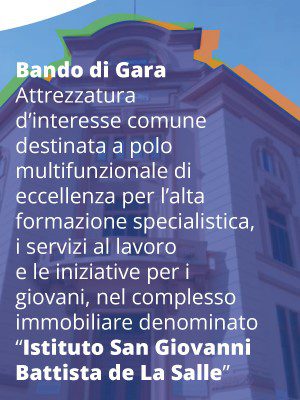
8 Commenti
gattone00
Ottobre 04, 14:20Azienda con dipendenti dove vige l’articolo 18 e non il job act.
Eufranio Massi
Novembre 16, 11:55Se un’azienda ha più di 15 dipendenti e chiude l’attività deve aprire la procedura di riduzione di personale ex art. 24 della legge n. 223/1991, seguendo quanto previsto nell’art. 4.
Se intende licenziare soltanto alcuni dipendenti per gmo (fino a 4 assunti prima del 7 marzo 2015, perché, altrimenti, deve aprire la procedura) deve attivare la conciliazione obbligatoria ex art. 7 della legge n. 604/1966 ( la procedura è ben descritta e ad essa rimando).
La procedura non può essere attivata dai lavoratori. Costoro, in caso di licenziamento, possono impugnare il recesso nelle sedi opportune.
Dott. Eufranio Massi
gattone00
Ottobre 04, 14:18Salve, volevo porle due quesiti. Dalla data del licenziamento per motivo oggettivo per finita locazione affitto azienda alla richiesta obbligatoria della conciliazione in un’azienda con più di 15 dipendenti, entro quanto tempo il datore deve fare richiesta alla direzione del lavoro?? E se questa richiesta non avviene è possibile che a promuoverla siano i dipendenti?? A cosa va incontro il datore di lavoro se non assolve questo obbligo?? Grazie
Patrizia Speziale
Giugno 22, 17:21Vista la pandemia i termini del licenziamento alla data del 12.02.2020 non vengono bloccati?
Eufranio Massi
Giugno 29, 10:51I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sono sospesi tra il 17 marzo ed il 17 agosto.
Dott. Eufranio Massi
Costanza
Maggio 04, 21:07Buonasera Dott. Massi, un chiarimento in merito alla bozza di decreto da lei commentata. Nella bozza c’è qualche riferimento a procedure di licenziamento collettivo i cui accordi si sono chiusi prima del 23 Febbraio ma i cui effetti (intesi come la data di licenziamento) si dovrebbero esplicitare nei prossimi mesi? La ringrazio anticipatamente e la saluto.
Eufranio Massi
Maggio 05, 11:19Nella bozza che ho visto non c’è alcun riferimento alla questione da Lei rappresentata.
Dott. Eufranio Massi
Flavia
Agosto 06, 11:22Gentilissimo, seguo con piacere le Sue rubriche e corsi di aggiornamento quando possibile.
Vorrei chiederLe un chiarimento in merito all’argomento della conciliazione obbligatoria per quanto riguarda i datori di lavoro interessati alla procedura. Le disposizioni dell’art. 7 Legge 604/1966 (e circolare 3/2013 Ministero del lavoro e politiche sociali) relativo al punto … nonchè il datore di lavoro…. che nell’ambito dello stesso comune occupa più di 15 lavoratori… anche se ogni unità produttiva non raggiunge singolarmente tali limiti e in ogni caso il datore di lavoro con più di 60 dipendenti.
Si riferisce al comune in cui il datore effettua i licenziamenti oppure può essere anche un’altro comune in cui opera l’azienda?