La nuova disciplina delle mansioni dopo la modifica dell’art. 2103 c.c. [E.Massi]
Innanzitutto, si parla di un accordo in “sede protetta” ove le parti dovrebbero rivolgersi di comune accordo, atteso che la norma ricollega le modifiche alla struttura contrattuale ad un interesse del lavoratore finalizzato:
- al mantenimento dell’occupazione. Tale motivazione potrebbe rinvenirsi tutte le volte che, al di fuori di una procedura collettiva di riduzione di personale (ove sussistono altre forme di garanzia), il lavoratore potrebbe essere destinatario di un provvedimento di recesso. In alternativa a questo si potrebbe ipotizzare un demansionamento anche per più di un livello, un cambio di categoria, di livello di inquadramento o della retribuzione (fatto, sempre, salvo, a mio avviso, il principio contenuto nell’art. 36 della Costituzione). Tale operazioni possono essere anche “a tempo”, nel senso che possono essere strettamente correlate all’andamento aziendale. C’è da sottolineare come tale ipotesi (mantenimento dell’occupazione) possa trovare applicazione anche nella ipotesi considerata al comma 2 ove si parla soltanto di un demansionamento al livello inferiore con il mantenimento del trattamento retributivo. Vale la pena di ricordare come, a partire dal 2008, nel pieno della crisi economica dalla quale il Paese sta faticosamente uscendo, molti accordi individuali di tale tenore (soprattutto con la rinuncia, anche temporanea, ad emolumenti economici legati a premi e mensilità aggiuntive) sono stati conclusi nelle c.d. “sedi protette”;
- alla acquisizione di una diversa professionalità. Tale motivazione potrebbe ricorrere in quei casi in cui, ad esempio, in un determinato reparto si stia sviluppando un prodotto innovativo e si registri un interesse del lavoratore, sulla base del proprio bagaglio formativo e professionale, a sviluppare una certa esperienza cambiando anche categoria di inquadramento;
- al miglioramento delle condizioni di vita. La motivazione che, da subito, viene in mente consiste nel trasferimento in una unità produttiva aziendale più vicina all’abitazione dell’interessato e tale da eliminare fenomeni di “pendolarismo”, cosa che potrebbe portare lo stesso ad accettare una diversa categoria di inquadramento, pur di veder realizzato il proprio obiettivo di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
L’accordo tra le parti va raggiunto in una “sede protetta” la quale, a mio avviso (e qui saranno, oltre modo, graditi i chiarimenti amministrativi che il Dicastero del Lavoro farà pervenire alle proprie articolazioni territoriali), attesa la delicatezza della questione, non potranno limitarsi a svolgere un compito “prettamente notarile”, ma dovranno evitare che si raggiungano “patti leonini”, a scapito del lavoratore interessato.
Un’altra riflessione riguarda le parti: sicuramente, sono pienamente validi i principi della delega alla rappresentanza ma è preferibile, che il lavoratore interessato, atteso che si tratta di una questione che attiene direttamente alla propria sfera personale, sia presente. Piuttosto, quest’ultimo può farsi assistere (e il Legislatore delegato non sembra ammettere altre persone) da un sindacalista, da un avvocato o da un consulente del lavoro. La norma ripete, sul punto, quasi pedissequamente, quanto già affermato dall’art. 7, comma 5, della legge n. 604/1966, come riformato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012: da ciò ne consegue come l’assistenza in conciliazione sia preclusa ad altri soggetti che, pur essendo equiparati ai consulenti ex lege n. 12/1979, furono esclusi dall’assistenza nel tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo una interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 3/2013, che suscitò parecchie rimostranze da parte dell’ordine dei commercialisti.
Un effetto indiretto della nuova formulazione delle mansioni si ravvisa, a mio avviso, nell’istituto del “repechage”, richiesto dalla giurisprudenza allorquando un datore di lavoro intende procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cancellazione del posto a seguito di nuova organizzazione interna, diminuzione dell’attività, calo di commesse, ecc.). Occorrerà, in caso di contenzioso, dimostrare, che nel caso della modifica degli assetti organizzativi interni sia stato offerto un nuovo posto di lavoro di livello inferiore (o che la cosa non è stata materialmente possibile). Al contempo, la previsione contenuta al comma 6 (offerta di un demansionamento, anche di categoria, da sottoscrivere in “sede protetta”) potrebbe essere oggetto di esame giudiziale nella valutazione circa la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a ”ragioni inerenti alla attività produttiva” . La Cassazione, con sentenza n. 6 del 2 gennaio 2013, ha affermato che il datore di lavoro ha l’onere di offrire una nuova collocazione al lavoratore e di avvertirlo che tale offerta rappresenta l’unica occasione alternativa al recesso dal rapporto di lavoro.
Ricordo, per completezza di informazione, che il mancato espletamento della procedura del “riassorbimento all’interno della struttura aziendale” determina la illegittimità del recesso con la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria (senza contribuzione), compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, liquidata dal giudice nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 8 della legge n. 604/1966 (art. 18 della legge n. 300/1970, come riformato dalla legge n. 92/2012): nelle piccole imprese l’indennità resta compresa tra 2,5 e 6 mensilità (legge n. 108/1990). Nel caso in cui la illegittimità riguardi lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 23/2015, l’importo sanzionatorio, non oggetto ad alcuna contribuzione, è pari a 2 mensilità all’anno, calcolate sull’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, partendo da una base di 4, fino ad un massimo di 24 (i valori sono ridotti della metà, con un tetto fissato a 6 mensilità, nelle aziende dimensionate fino a 15 dipendenti e nelle imprese di tendenza).
La modifica della disciplina delle mansioni, a mio avviso, avrà effetti anche sul contenzioso economico legato al “mancato sviluppo della professionalità”: essendo, normativamente, prevista la possibilità del demansionamento in presenza di situazioni certe ben definite sia dalla legge che da accordi sindacali, lo stesso potrebbe subire drastiche riduzioni.
Con il comma 7, il Legislatore delegato detta nuove regole per l’affidamento di mansioni superiori. L’assegnazione diviene definitiva, fatta salva la rinuncia dell’interessato, prima non prevista e che, comunque, dovrebbe avvenire per iscritto, nel caso in cui le stesse siano state esercitate, in maniera continuativa, per il periodo fissato negli accordi collettivi, anche aziendali: in mancanza, il termine viene fissato in 6 mesi continuativi. Nella sostanza, il limite di 3 mesi stabilito nel vecchio articolo 2103 c.c., ripreso nella gran parte della contrattazione collettiva, viene raddoppiato ma, in presenza di pattuizioni diverse, esso non viene in rilievo.
Il riferimento alla continuità delle mansioni superiori per un arco semestrale, non dovrebbe consentire un uso capzioso con aggiramento della disposizione in tutti quei casi in cui il datore di lavoro adibisca più volte e reiteratamente, con stacco, il lavoratore per periodi inferiori che, sommati, superano ampiamente il limite dei sei mesi. Ciò potrebbe configurarsi come un “negozio in frode alla legge” e, come tale, sanzionato dal giudice di merito.
Le mansioni superiori non maturano se “l’assegnazione abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio”: la frase adottata appare più ampia di quella precedente ove si parlava “di sostituzione di lavoratore avente diritto alla conservazione del posto”.
Rientrano, senz’altro, nella previsione normativa le “classiche” sostituzioni di lavoratori assenti per ferie, malattia, maternità e, in genere, quelle legate alle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto, ma la nuova formula adottata sembra appositamente dettata dalla necessità di superare alcune interpretazioni giurisprudenziali oggetto di valutazioni diverse.
Il comma 8, ripete un precetto già presente nel vecchio art. 2103 c.c.: “il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. Da ciò discende che, per giurisprudenza costante, il lavoratore possa essere trasferito:
- perché necessario, attesa la sua professionalità, nell’altra unità produttiva;
- perché la scelta, in virtù delle specifiche competenze, è caduta sullo stesso e non su altri colleghi che svolgono analoghe mansioni;
- perché lo stesso non è utilizzabile proficuamente, sotto l’aspetto della organizzazione produttiva interna, nella sede di provenienza.
Il trasferimento, con le relative motivazioni, va comunicato per iscritto e, ovviamente, presuppone che resti invariata la titolarità del datore di lavoro, essendo completamente diversa sia l’ipotesi del passaggio alle dipendenze di un altro datore, sia pure collegato o consociato con il primo, che quella del distacco temporaneo presso altro datore regolamentato dall’art. 30 del D.L.vo n. 276/2003..
Si può parlare di trasferimento pur se le unità produttive insistono sullo stresso ambito comunale? Anche nella nuova norma non si rileva alcuna indicazione riferita alla distanza tra la sede di origine e quella di destinazione.
Piuttosto, va chiarito il concetto di unità produttiva: secondo la Cassazione (Cass., 26 maggio 1999, n. 5153), in un’ottica di tutela del lavoratore va data una lettura diversa. In caso di trasferimento in altro ambito comunale, con conseguenti disagi personali e familiari, il concetto di unità produttiva va inteso come articolazione organizzativa dell’impresa, caratterizzata da un minimo di complessità e intesa alla realizzazione di una o più parti dell’impresa. Nell’ipotesi, invece, di trasferimento in ambito comunale, il pregiudizio sofferto dal lavoratore è minore e, quindi, secondo la Suprema Corte, la nozione di unità produttiva segue la definizione che si ricava dall’art. 35 della legge n. 300/1970.
Vale la pena di ricordare come nulla sia cambiato per quel che concerne il trasferimento di un dirigente della rappresentante sindacale per il quale è necessario il nulla – osta della organizzazione di appartenenza (art. 22 della legge n. 300/1970), della impossibilità del trasferimento, senza richiesta o consenso, dei lavoratori dipendenti eletti consiglieri negli Enti elettivi territoriali (art. 27 della legge n. 816/1985), della impossibilità di trasferire, senza consenso, chi assiste in maniera continuativa ed esclusiva un figlio od un parente disabile (art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e art. 20 della legge n. 53/2000), mentre appare pacifica in giurisprudenza la possibilità che un lavoratore venga trasferito allorquando una infrazione di natura disciplinare si accompagni a ragioni tecniche ed organizzative come, ad esempio, in situazioni di incompatibilità ambientale che costituiscono causa di disfunzione e disorganizzazione all’interno della unità produttiva determinate da difficili rapporti personali tra colleghi e diretti superiori (Cass., n. 12088/1991; Cass., n. 3389/1989).
Ma, cosa succede in caso di trasferimento non supportato dalle condizioni richieste dall’art. 2103 c.c.?
Fermo restando che appare sempre possibile il ricorso ex art. 700 cpc, si è orientati a ritenere nullo, per violazione di una norma imperativa, il trasferimento adottato senza le comprovate esigenze aziendali ed a ritenere illegittimo il provvedimento di licenziamento intimato a seguito del rifiuto a dar seguito ad un trasferimento non supportato da una motivazione ex art. 2103 c.c. .
Per completezza di informazione ricordo che il trasferimento, per effetto della legge n. 183/2010, deve essere impugnato entro i 60 giorni successivi dalla ricezione della comunicazione e che i termini per depositare il ricorso in giudizio scadono nei 180 giorni successivi.
Ma, su questo ed altri argomenti, sarà necessario tornare a riflettere in futuro, dopo questo primo commento.
Il comma 9 ribadisce la nullità di ogni patto contrario alla previsione dell’art. 2103 c.c. ma, a differenza del passato, ove la disposizione era “tranchant” sull’argomento, sono fatte salve le condizioni previste dai commi 2 (modifica degli assetti organizzativi), 4 (ipotesi fissate dalla contrattazione collettiva) e 6 (accordo tra le parti in “sede protetta”).
Da ultimo, il Legislatore delegato interviene sulla legge n. 190/1985 che riguarda il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi, abrogando l’art. 6 con il quale si affermava che in deroga a quanto previsto dall’art. 2103 c.c., l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori o a mansioni dirigenziali, che non era avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diveniva definitiva se si era protratta per tre mesi o per il periodo superiore fissato dalla contrattazione collettiva. Tutto questo appare coerente con la nuova disciplina contenuta nell’art. 2103 c.c. riformato.
Pages: 1 2
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.





 Posizioni aperte nel settore trasporti per Milano Cortina 2026
Posizioni aperte nel settore trasporti per Milano Cortina 2026 Tirocini di inclusione sociale GOL Campania – Avviso Alto Calore Servizi
Tirocini di inclusione sociale GOL Campania – Avviso Alto Calore Servizi CCNL metalmeccanici industria: causali nei contratti a termine
CCNL metalmeccanici industria: causali nei contratti a termine Legge di Bilancio 2026: tutte le risposte alle domande degli utenti
Legge di Bilancio 2026: tutte le risposte alle domande degli utenti
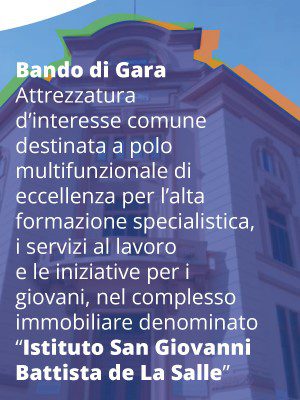




10 Commenti
luca
Aprile 21, 21:56Domanda: è possibile per un dipendente della Pubblica Amministrazione in quadrato in cat. D1 (Enti Locali) richiedere all’Amministrazione di appartenenza un sotto inquadramento in sede protetta verso la cat. C5 (enti locali) per “perfezionare” una proceduta di mobilità ed essere inquadrato adeguatamente nell’ente pubblico di destinazione (ministero) per la quale è stato riconosciuto vincitore?
Grazie
Eufranio Massi
Aprile 26, 14:06Caro Luca,
non credo che sia possibile per due ragioni:
A) non credo che il,comma 6 del nuovo art. 2013 c.c. si applichi anche al pubblico impiego se la norma non verrà richiamata nei c.d. decreti Madia sul pubblico impiego;
B) il comma 6 si riferisce a tre ipotesi che riguardano il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore e non altri futuri ( salvaguardia del posto di lavoro, acquisizione di una diversa professionalità, miglioramento delle proprie condizioni di vita): in tale logica, quand’anche fosse possibile anche nel settore pubblico, riterrei che il suo caso non possa rientrare tra le ipotesi in quanto riguarda un altro rapporto.
Dott. Eufranio Massi
pasquale
Marzo 25, 15:15salve, son dipendente del comune di Qualiano NA, cat. B/6, responsabile CED e sistemi informativi da 5 anni ininterrottamente con decreto dirigenziale, volevo domandare: ma il job act vale anche per i dipendenti pubblici?, fino ad adesso nessuno ha saputo dare una risposta.
Eufranio Massi
Marzo 29, 10:23La legge delega n. 183/2014 non fa alcuna specifica esclusione, ma ritengo che con la riforma del settore pubblico quale si sta attuando con i decreti legislativi attuativi della legge che riforma il pubblico impiego, sia proprio quest’ultima che troverà applicazione, attesa la specialità della disposizione.
Dott. Eufranio Massi
antonio
Marzo 24, 21:55Salve, sono dipendente del Consorzio Industriale, Ente pubblico economico, inquadrato nella categoria C livello 1, tra qualche giorno sarà attuata la c.d. rotazione del personale e allo scrivente è stato proposto il trasferimento agli Affari Generali affidandogli il personale. Preciso che fino ad oggi il settore del personale era stato attribuito al collega con inquadramento categoria Q livello 1 (superiore rispetto alla C). Nel caso l’ordine di servizio preveda che allo scrivente sia attribuita la diretta responsabilità del personale, potrei chiedere, come previsto dal CCNL, trascorsi i tre mesi la categoria superiore e cioè la Q? Nel caso, invece, l’ordine di servizio preveda che lo scrivente venga nominato solo “coadiutore” del titolare (non è dipendente del’Ente ma ha solo un contratto di collaborazione temporale da qualche tempo) del settore personale, ha diritto al livello superiore?
Il job act è applicabile anche agli enti pubblici economici?
Grazie anticipatamente
Antonio
Federico
Dicembre 19, 09:52Buongiorno,
ho assistito ieri al sua trattazione al convegno a Perugia e mi è sorta una domanda specifica in merito al licenziamento/demansionamento/diritto di repercharge.
Ipotizziamo che in un azienda:
1) ci sia un impiegato qualificato alto livello con retribuzione di 2.500 €;
2) che l’azienda abbia necessità di licenziare tale impiegato per soppressione dell’ufficio;
3) che allo stesso tempo l’azienda abbia necessità di assumere una segretario di basso livello (oltre un livello più basso rispetto all’impiegato specializzato in esubero) con retribuzione di 1.500 €;
4) che l’azienda offra all’impiegato di alto livello un demansionamento in sede protetta con riduzione dello retribuzione (dai 2500€ ai 1500€) offrendo di fatto il posto di segretario invece di assumere una nuova persona;
5) che l’impiegato qualificato rifiuti l’offerta.
L’azienda a suo avviso può procedere al licenziamento? O avrebbe l’obbligo di offrire all’impiegato specializzato il posto da segretario mantenendogli il medesimo livello di retribuzione?
Mi rendo conto che probabilmente è una domanda la cui risposta non può essere certa ma è sottoposta ad una certa alea, ma mi interesserebbe sapere la sua opinione in merito.
Grazie
Cordiali Saluti
Eufranio Massi
Dicembre 22, 08:07Caro Federico,
Le rispondo volentieri.
Il repechage è’ un istituto di origine giurisprudenziale che viene costantemente richiesto allorquando un datore di lavoro abbia affettato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sia pendente un ricorso giudiziale contro lo stesso.
Detto questo e fermo restando che la risposta non può essere certa per evidenti motivi ( il tutto andrebbe visto alla luce della situazione aziendale e di quella concreta che si riferisce all’organizzazione della stessa) credo che il datore di lavoro potrebbe proporre un demansionamento ( potendo l’imprenditore offrire un posto di lavoro inferiore a quello già occupato) ai sensi del comma 6 dell’art 2103 c.c. e che l’eventuale rifiuto dell’interessato possa costituire adempimento all’obbligo di repechage, se la nuova collocazione viene rifiutata dall’interessato.
Non credo attivabile il comma 2 con il demansionamento di un solo livello all’interno della stessa categoria legale (in quanto, mi sembra, che non ci possano essere 1000 euro di differenza) e perché tale prerogativa dipende dalla volontà del datore di lavoro.
Nella speranza di essere stato chiaro, Le porgo i miei più cordiali saluti ed auguri per le prossime festività.
Dott. Eufranio Massi
Fabio
Marzo 15, 00:39Buona sera dott. Massi,
mi ricollego all’ultima parte della Sua risposta per un chiarimento.
Si dia il caso di un’azienda che, per ragioni di contenimento dei costi, voglia ridurre il livello di inquadramento di alcuni lavoratori con quello immediatamente inferiore, comunque corrispondente alle mansioni da svolgere (in quanto la differenza tra i due livelli risulta dipendere nel CCNL dall’utilizzo di mezzi d’opera più complessi, oggi in disuso, sostituiti da altri più semplici per i quali è previsto il livello di inquadramento inferiore).
Dal combinato dei commi 2 e 5 la riduzione sembrerebbe possibile, ma con la garanzia del medesimo trattamento retributivo; il che tuttavia porrebbe nel nulla le ragioni della riorganizzazione stessa.
L’azienda, per proporre la riduzione dei livelli, deve quindi necessariamente passare attraverso una procedura di licenziamento (individuale o collettivo, a seconda delle unità coinvolte), offrendo contestualmente al lavoratore il mantenimento dell’occupazione al livello (ed alla retribuzione) inferiore?
Ringraziando anticipatamente,
Cordiali saluti
Fabio
pasquale pianese
Luglio 31, 19:27ma il job act riguardo alle mansioni superiori è valido anche per il pubblico impiego?
saluti
Pasquale Pianese resp. CED del comune di Qualiano NA
Eufranio Massi
Agosto 01, 11:06Nel settore pubblico la disciplina delle mansioni e’ regolamentata dall’art. 52 del Decreto Legislativo n. 165/2001